





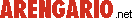
Uccidere in nome di un Dio
Josè Saramago su la Repubblica
…
È stato già detto che le religioni, tutte, senza eccezione, non serviranno mai per avvicinare e riconciliare gli uomini, e che, al contrario, sono state e continuano a essere causa di sofferenze inenarrabili, di stragi, di mostruose violenze fisiche e spirituali che costituiscono uno dei più tenebrosi capitoli della misera storia umana. Almeno come segno di rispetto per la vita, dovremmo avere il coraggio di proclamare in tutte le circostanze questa verità evidente e dimostrabile, ma la maggioranza dei credenti di qualsiasi religione non solo finge di ignorarla, ma si leva iraconda e intollerante contro coloro per i quali Dio non è altro che un nome, nient'altro che un nome, il nome che, per paura di morire, un giorno gli abbiamo messo e che sarebbe venuto a sbarrarci il passo per un'umanizzazione reale. In cambio, ci hanno promesso paradisi e ci hanno minacciato con inferni, tanto falsi gli uni come gli altri, insulti sfacciati a un'intelligenza e a un senso comune che ci è costato tanto far crescere. Dice Nietzsche che tutto sarebbe permesso se Dio non esistesse, e io rispondo che precisamente per causa e in nome di Dio si permette e si giustifica tutto, principalmente il peggio, principalmente ciò che è più orrendo e crudele.
…
Eppure, nonostante tutto, Dio è innocente. Innocente come qualcosa che non esiste, che non è esistito né esisterà mai, innocente di aver creato un universo intero per collocarvi degli esseri capaci di commettere i più grandi crimini per poi venire a giustificarsi dicendo che sono celebrazioni del suo potere e della sua gloria, mentre i morti si vanno accumulando, questi delle torri gemelle di New York e tutti gli altri che, in nome di un Dio divenuto assassino per volontà e per azione degli uomini, coprono e continueranno a coprire di terrore e di sangue le pagine della Storia. Gli dèi, secondo me, esistono solo nel cervello umano, prosperano o si consumano nello stesso universo che li ha inventati, ma il "fattore Dio", questo sì, è presente nella vita come se ne fosse effettivamente il padrone e signore. Non è un dio, ma il "fattore Dio" quello che si esibisce nei dollari e che si mostra nei cartelli che chiedono per l'America (quella degli Stati Uniti, non l'altra.) la benedizione divina. Ed è il "fattore Dio" in cui il dio islamico si è trasformato che ha scagliato contro le torri del World Trade Center gli aerei della rivolta contro i disprezzi e della vendetta contro le umiliazioni. Si potrebbe dire che un dio è andato a seminare venti e che un altro dio risponde ora con tempeste. È possibile, anzi è sicuro. Ma non sono stati loro, poveri dèi senza colpa, è stato il "fattore Dio", quello che è terribilmente uguale in tutti gli esseri umani dovunque siano e qualunque sia la religione che professano, quello che mantiene intossicato il pensiero e aperte le porte alle intolleranze più sordide, quello che non rispetta se non ciò in cui comanda di credere, quello che dopo essersi vantato di aver fatto della bestia un uomo ha finito col fare dell'uomo una bestia.
…
Copyright El Pais
La fine dell'innocenza americana
Carlo De Benedetti su la Repubblica
SAREI dovuto salire al 106 piano del World Trade Center. Avrei dovuto raccontare ai promotori americani dove investire. Avrei dovuto parlare della crisi che sta colpendo i titoli hi-tech. Avrei dovuto spiegare che valeva la pena avere coraggio, anche in quella congiuntura sfavorevole. Avrei dovuto. Ma non l'ho potuto fare. Perché il 13 settembre, giorno in cui era fissata l'annuale conferenza dell'Economist sui fondi di investimento, il World Trade Center non esisteva più. Perché le torri più alte del mondo erano crollate, ferite a morte dalla ferocia del fanatismo. Perché gran parte della platea di gestori e investitori che avrebbe dovuto ascoltare quel mio intervento era ormai sepolta, in una gigantesca bara d'acciaio.
La tragedia dell'America l' ho vissuta con gli americani. Il 10 settembre, infatti, ero a Washington per alcuni incontri di lavoro. E l'11 avrei dovuto trasferirmi a New York. La notizia degli attacchi mi è arrivata proprio mentre ero in partenza per Manhattan. Così mi sono fermato nella capitale Usa. Dove sono rimasto bloccato dalla completa paralisi dei trasporti fino a domenica scorsa. Ho anche tentato di raggiungere il Canada in autobus o in treno, ma è stato inutile.
…
Ho avuto giornate intere per riflettere.
Alla fine qualche idea me la sono fatta. E la prima, purtroppo, è un'idea di sconfitta. Dopo quello che è accaduto, gli Stati Uniti non potranno più essere gli stessi. Noi europei abbiamo millenni di storia e di guerra alle spalle, la nostra è ormai una società disincantata. L'America, fino a ieri, non aveva mai visto scorrere sul proprio suolo il sangue dei propri figli per mano nemica. Viveva nell'illusione dell'incanto e dell'innocenza. Tutto questo giace ora, con migliaia di corpi, sotto le tonnellate di polvere in cui si sono disintegrate le Torri gemelle.
Quello americano – scriveva qualche giorno fa l'Economist, non senza un pizzico di rimpianto – "was a fool's paradise", era il paradiso dei folli. Una società in cui l'imperativo principale era la libertà. Libertà a tutti i costi, anche a scapito della sicurezza.
…
Quanti vincoli e quante barriere si erigeranno sin da domani. E quei muri, per reazione, saranno più forti di quel che sarebbe necessario. La ricerca di una maggior sicurezza si tradurrà giocoforza in una minore libertà. L'America del nolimits finirà per sempre. Ce ne accorgeremo tornando al JFK o a Newark: più controlli, più file, più burocrazia. Ma non solo. L'onda d'urto di questa inversione di rotta arriverà anche in Europa. Viaggiare sarà più difficile; lo sguardo occhiuto delle intelligence di tutto il mondo lederà la nostra privacy; le merci, i capitali, le persone circoleranno meno velocemente.
In una parola, saremo meno liberi.
…
Tra le sicurezze che abbiamo smarrito c'è quella della solidità del mercato finanziario e delle nostre economie. C'è chi dice, ora, che tra gli obiettivi di Bin Laden ci fosse anche quello di speculare al ribasso sul crollo dei titoli di borsa. Di certo i kamikaze puntavano a destabilizzare la fiducia nel sistema finanziario internazionale: un obiettivo che è stato raggiunto. Wall Street ha tenuto: non c'è stato panic selling. Ma l'economia globalizzata ha improvvisamente mostrato tutta la sua fragilità. L'effetto terrorismo si è aggiunto alla crisi congiunturale. E ora ci vorranno decenni prima che gli investitori recuperino coraggio e tornino in massa sul mercato.
Ecco perché i barbari distruttori del World Trade Center la loro vittoria l'hanno già incassata: hanno strappato agli Usa la loro innocenza, hanno costretto l'Occidente a essere meno libero, hanno destabilizzato il mercato globale.
Ma ora sta agli americani e a tutti noi impedire che la nostra sconfitta si traduca in una debacle ancor più generalizzata.
…
Sono rimasto sorpreso nel sentir pronunciare dal Presidente George W. Bush la parola "guerra". Questa non è una guerra. Non fosse altro che per il fatto che non ci sarà mai una pace. Tutte le guerre, dalla più lunga alla più breve, sono sempre finite con la firma di una pace. Questa volta, però, non sarà possibile. Perché l'avversario non è uno Stato, ma un inestricabile intreccio di organizzazioni terroristiche. E il terrorismo non si sconfigge con la guerra e non firma trattati di pace.
…
Ho accolto con speranza le prese di posizione contro il terrorismo dei tanti islamici sparsi per il mondo: un'alleanza tra civiltà, questo deve essere lo sbocco, e non quel "Clash of Civilizations" annunciato da Samuel Huntington.
…
Tra le cose più sensate che ho sentito dire in quei miei giorni a Washington è che ora l'America, insieme con il suo orgoglio, deve riscoprire la sua modestia. Non solo non dovrà reagire da sola, ma dovrà reagire con la calma consapevolezza di chi sa che non esiste una sola verità, che la propria organizzazione sociale è solo una delle tante possibili, che la propria cultura trova il suo apice nella tolleranza verso le altre culture. Il modello occidentale ha una sua "naturale" tendenza espansiva. Ma troppo spesso l'America ha dato l'impressione di voler monopolizzare il modo di organizzarsi e di vivere di popolazioni con antiche e differenti tradizioni. Quell'errore, ora più che mai, non va ripetuto.
…
La trappola dello scontro fra civiltà
Bernard-Henri Lévy su Corriere della Sera
Di questi tempi si parla nuovamente di quel professore americano, Samuel Huntington, il quale dieci anni fa, dopo la caduta del Muro di Berlino, annunciava la comparsa di un nuovo conflitto, che sarebbe stato il conflitto del XXI secolo e che ci avrebbe posto contro l'Islam. Credo che Huntington abbia torto. Più esattamente, credo che le democrazie vinceranno la guerra appena dichiarata contro di loro solo se rifiuteranno, con tutte le forze, di cedere alle semplificazioni manichee della teoria dello "scontro di civiltà".
…
E lo penso per tutta una serie di ragioni: teologiche, strategiche, quasi semantiche.
Semantiche: che bel regalo al terrorismo, quando si qualifica la guerra che esso ci dichiara come una guerra "di civiltà"! Che vittoria, per gli assassini, se vedessero che alla loro barbara guerra, alla loro guerra di non-civiltà, si pone l'aureola del meraviglioso prestigio di uno scontro fra "visioni del mondo"!
Strategiche: nessuno sa cosa voglia Bin Laden; nessuno, forse neanche lui, conosce il suo programma, il suo progetto. Una cosa, comunque, è chiara: che egli sogna, in realtà, di vedere l'intero mondo arabo-musulmano precipitare nell'odio verso l'Occidente
…
Infine, teologiche: pur non essendo, per carità, uno specialista dell'Islam, so - come tutti sappiamo - che l'Islam non è un blocco; e che, oggi come ieri, l'Islam è teatro di uno scontro d'eccezionale intensità fra i sostenitori della regressione e le menti illuminate che rifiutano la caricatura che certuni fanno della loro fede; se la guerra, in altri termini, non oppone l'Occidente all'Islam, significa che essa passa all'interno dell'Islam stesso; noi la vinceremo, questa guerra, solo se, domani, impiegheremo la stessa energia a sostenere quelle correnti liberali di quanta presto ne metteremo nel colpire come si deve tutti coloro che, da vicino o da lontano, hanno partecipato alla carneficina.
Un'ultima parola. Mi è difficile non scrivere il nome di colui che fu l'incarnazione di questo Islam illuminato in lotta contro l'integralismo: il comandante Massud.
…
Stranamente è stato ucciso poco prima dell'attacco contro New York; tutto s'è svolto come se la moderna setta degli assassini, decisamente esperta in terrore, avesse anticipato la risposta americana e l'avesse privata, in anticipo di chi, sul campo, sarebbe stato il migliore alleato: altra ragione per evocarlo.
…
Ricordo la mia ultima conversazione con Massud. Egli si chinò su una carta geografica, mise il dito sulla città di Kandahar: "Bin Laden è qui, in una casa prestata dal mullah Omar, il capo dei talebani, nella sua stessa strada".
Bernard-Henri Lévy
La paura globale
Enzo Biagi su Corriere della Sera
…
Quello che è accaduto a New York è una prova che esiste anche la globalizzazione della follia e della vendetta: Piazza del Duomo, Piazza Tienanmen, Piccadilly Circus, Rockefeller Center o Place de la Concorde, lì può darsi appuntamento lo sgomento di queste ore insicure: non esistono isole felici.
Ma questi fatti che non hanno una sola patria e che ci riguardano non debbono essere un alibi per non affrontare anche le nostre storie, per fugare le ombre o allontanare decisioni che possono rendere più limpida la nostra politica: ci sono, ad esempio, conflitti di interesse che aspettano da sempre di essere sistemati, e che non dipendono minimamente dalle iniziative dei talebani.
Il falso in bilancio non ha niente a che vedere con l'impegno che ha preso Bush davanti al suo popolo: "Voglio Bin Laden morto o vivo".
…
E a proposito: una conferma che nel dramma c'è sempre una nota comica: il rito delle ampolle con l'acqua del Po celebrato dal leader della Lega l'altro giorno, in nome degli antenati Celti, dei quali si hanno vaghe nozioni.
Credevamo che le crociate contro gli infedeli appartenessero ormai ai manuali scolastici: ma c'è sempre un "impero del male".
…
La guerra rimossa
Renzo Foa su il Giornale
La parola guerra perché all'improvviso è diventata, in Italia, cosi' difficile da pronunciare? Perché nel mondo politico è quasi un tabù, rotto soltanto dal presidente del Consiglio Berlusconi all'uscita dall'incontro con Blair? Eppure, nell'enfasi che impregna la nostra comunicazione, non solo quella televisiva o stampata, ma anche quella tra le persone, se ne è spesso abusato e a sproposito. Per esempio se ne parla in continuazione associandola agli incidenti negli stadi, al bilancio dei morti sulle strade, ai fenomeni della grande criminalità, perfino ai dibattiti parlamentari. Ma ora - ora che una guerra è davvero iniziata con l'attacco su Manhattan e su Washington - si ricorre a termini diversi, più blandi. E se proprio non si puo' fare a meno di scriverla o di sillabarla si precisa che è di Bush, dell'America, della Nato, quasi ci riguardasse da lontano. È per pudore? Per uno scarso coraggio di fronte alla peggiore delle prospettive che una società puo' trovarsi ad affrontare? O c'è un problema irrisolto che riguarda la storia culturale e politica italiana? Se si guarda al passato più recente, solo agli ultimi dieci anni, ci rendiamo conto che in questo atteggiamento c'è una costante. Basta citare due casi. La partecipazione italiana alla liberazione del Kuwait, cioè all'operazione "Tempesta nel deserto", fu un'"operazione di polizia internazionale", secondo la formula coniata dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. I bombardamenti della Nato sulla ex Jugoslavia per porre fine alla pulizia etnica attuata dal regime serbo in Kosovo, a cui partecipo' anche l'aviazione militare del nostro Paese, furono definiti soprattutto "un intervento umanitario". Certo, la risposta a Saddam Hussein fu anche "un'operazione di polizia" e quella, più efficace, data a Milosevic "un intervento umanitario". Ma in entrambi i casi si trattava in primo luogo di guerre. Guerre, a essere precisi, iniziate da altri e in cui anche l'Italia interveniva.
Oggi la tentazione di non voler chiamare le cose con il loro nome continua a essere irresistibile. Questo avviene per un complesso di ragioni. Forse la più importante è di natura storica ed è la lunga ombra lasciata dalla distesa di macerie del 1945, I'"anno zero", dell'Europa che conosciamo oggi, anche se si è davvero compiuta solo nel 1989. C'è una memoria sotterranea che si tramanda di generazione in generazione e che fa di quel passato il maggiore simbolo del male, al punto che c'è l'abitudine di periodizzare quasi sessant'anni di "pax europea", dimenticando perfino le centinaia di migliaia di morti nella ex Jugoslavia. Se lontani appaiono ora i tre anni - in realtà così vicini - dell'assedio di Sarajevo, figuriamoci quanto remoti appaiono ora sia il Vietnam, sia la crisi dei missili a Cuba con il suo incubo nucleare, sia tutte le guerre in Medio Oriente. Remoti, ma soprattutto etichettati con altri marchi.
…
Perché aver paura di dire e di ripetere che siamo in guerra?
…
Questa rinuncia all'uso delle parole può diventare pericolosa, può provocare equivoci, può scavare un fossato tra un'opinione pubblica che ha capito quello che è successo e un mondo politico che, nella sua grande maggioranza, tentenna nel trarne pubblicamente le conseguenze. Mentre al luogo comune secondo cui la parola pace unisce e la parola guerra divide si può contrapporre un'obiezione molto semplice: è certamente ingiusta una pace durante la quale una città può venire bombardata all'improvviso, come è successo a Manhattan, e può essere molto giusta una guerra per impedire che questo si ripeta per difendersi e per affermare alcuni valori universali, come la vita e la democrazia.
Conti pubblici risanati: la svolta nel 1997
Su il Sole24ore
Positivo giudizio dell'Istat sul processo avviato nell'ultimo decennio. Con l'ingresso nell'euro adottata "una coerente politica di bilancio che ha accelerato la discesa dei tassi di interesse, con effetti rilevanti in termini di riduzione della spesa"
L'Istat promuove il processo di risanamento dei conti pubblici portato avanti in Italia negli ultimi anni. E a sostegno del giudizio cita l'andamento del risparmio, vale a dire la differenza fra risorse e impieghi di parte corrente: il dato, si legge nell'Approfondimento sugli aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche 1990-2000, diventa positivo nell'ultimo biennio, a testimonianza della "robustezza" del processo portato avanti. Uno sforzo trainato innanzitutto dal contenimento delle spese correnti, visto che le uscite in conto capitale "non sono variate in maniera significativa" e soprattutto che la pressione fiscale (42,4% nel 2000) si mantiene inferiore dello 0,7% rispetto alla media di Eurolandia e dello 0,4% rispetto a quella di tutti e 15 i Paesi dell'Unione europea. Quanto allo scostamento tra indebitamento netto, parametro ufficiale per il rispetto dei criteri fissati dal Patto di stabilità europea, e fabbisogno, l'Istat sostiene che la divergenza continuerà anche nei
prossimi anni, senza che il primo finisca per scaricarsi sul secondo, come nei timori del ministero dell'Economia.
Il processo di risanamento
…
Nel trentennio precedente al 1998, il saldo corrente si era mantenuto costantemente negativo "generando una permanente necessità di ricorso al mercato per il finanziamento dell'attività corrente di esercizio, e costituendo, per questa via, il principale fattore di accumulazione del debito pubblico". Con l'inversione di rotta degli ultimi tre anni il risparmio diventa invece "una delle principali fonti di finanziamento degli interventi in conto capitale".
Le spese
Dal picco del 57% in rapporto al Pil toccato nel 1993, si sono ridotte costantemente fino al 46% del 2000.
…
Le entrate
Anche l'aumento delle entrate ha fatto la sua parte nel processo di rientro dal deficit. Il peso delle tasse ha raggiunto il picco del 44,5% del Pil nel 1997 con l'Eurotassa, per poi tornare a calare fino al 42,4% del 2000.
…
La pressione fiscale è comunque in Italia inferiore dello 0,7% rispetto alla media dei paesi di Eurolandia e dello 0,4% rispetto a quella delle 15 nazioni che compongono l'Unione europea. In particolare, tutti i paesi Uem dell'Europa centro-settentrionale, come la Germania e soprattutto la Francia, con la sola eccezione dell'Olanda, presentano un carico fiscale superiore a quello italiano.
Lo scostamento tra indebitamento e fabbisogno
L'andamento dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e quello del fabbisogno del settore pubblico non presenta scostamenti significativi fino al 1997.
…
Tg La7
Lerner lascia. Al suo posto Rizzo Nervo
su Liberazione
Dal primo ottobre Gad Lerner non sarà più direttore del tg di La7. Al suo posto subentrerà l'attuale vice direttore Nino Rizzo Nervo. La tormentata vicenda televisiva di quello che doveva essere il terzo polo televisivo, in grado di contrastare il duopolio Rai-Mediaset, non accenna a sopirsi. Ieri l'annuncio ufficiale al cdr della testata da parte dell'amministratore delegato Ernesto Mauri e del direttore generale Giuseppe Ferrauto. Il nuovo tg di La7, nell'intento del nuovo direttore Rizzo Nervo non sarà una Cnn made in Italy, "non scherziamo per favore", ma un nuovo polo informativo con tg. Ci saranno approfondimenti, speciali ma anche "un palinsesto flessibile, in progress".

 20 settembre
20 settembre
![]() 20 settembre
20 settembre